 Rating4.6
181 reviews
Psicologa a Vicenza - Dottoressa Cristiana Brunetti : ARTICOLI/Articoli/Difficolt/I social network guida per luso
I social network guida per luso.
Rating4.6
181 reviews
Psicologa a Vicenza - Dottoressa Cristiana Brunetti : ARTICOLI/Articoli/Difficolt/I social network guida per luso
I social network guida per luso.


Qualche giorno fa mi è capitata tra le mani la mia tesi di laurea triennale, la quale aveva come obiettivo l’analisi psicologica dei social network, in particolare rispetto all’utilizzo che ne fanno gli adolescenti.
In quegli anni (la tesi risale all’anno accademico 2011/2012) Twitter e Facebook erano presenti nelle vite di alcuni di noi già da qualche anno; Instagram stava facendo capolino nel contesto italiano e tra alcuni, soprattutto i più giovani, veniva già utilizzato regolarmente, ma di sicuro non era quel fenomeno che è adesso (superato, peraltro, da social più recenti, tra i quali cito Tiktok, il preferito dei più piccini). All’epoca, Instagram aveva solo una bacheca su cui postare delle foto; non esistevano ancora le “storie”, che ci permettono di essere connessi h24 con i nostri “follower”, e non esistevano i “filtri” da porre su queste, responsabili di modificare la realtà e la nostra apparenza fisica.
Il 2012 per alcuni di noi può sembrare un periodo così vicino, eppure, pensando al progresso tecnologico che ha visto la creazione di smartphone e tablet sempre più moderni, di piani tariffari per l’accesso ad internet sempre più agevoli, e di nuovi social-media, la cui diffusione è aumentata a macchia d’olio divenendo ormai parte fondamentale della vita di tutti noi, sembra un periodo molto lontano.

Ritengo che la risposta alla prima domanda sia che, si, molto di quanto avevo scritto all’epoca vale ancora oggi, ma in misura maggiore. Ciò è dovuto alla maggiore diffusione di queste piattaforme e alle più recenti implementazioni tecnologiche che queste ci propongono. Se inizialmente i social erano utilizzati esclusivamente per restare in contatto con i propri amici e per esprimere opinioni e commenti circa situazioni della vita personale o sociale, adesso sono utilizzati anche per stringere nuove amicizie, per creare contatti professionali e infine per esprimere e realizzare le proprie aspirazioni.
È ormai un dato oggettivo, e noto ai più, che i social abbiano ampliato i limiti della comunicazione tradizionale, trasferendola in una dimensione virtuale dove si oltrepassano i confini reali del sé, e in cui il corpo, come ogni altro legame con la realtà, perde la propria concretezza.
La trasformazione dei contenuti mediali in vere e proprie esperienze a cui assistiamo oggi, ha come principale risultato la progressiva scomparsa del confine che separava in maniera netta il mondo reale da quello virtuale. Il risultato di questo processo è l’interrealtà [Riva 2009; 2010; Van Kokswijk 2003]: uno spazio ibrido che include tutte le esperienze –digitali e reali, pubbliche e private –sperimentate dal soggetto nella sua vita quotidiana. A caratterizzare l’interrealtà è lo scambio esistente tra le diverse dimensioni: il mondo virtuale influenza quello reale e viceversa; la dimensione pubblica influenza quella privata e viceversa.
Nella comunicazione sui social il soggetto si trova immerso in una situazione di massa, virtuale ma estremamente coinvolgente. La rete è dunque uno spazio che permette di "vedere" le menti umane in azione. Eppure internet ci colpisce per le sue caratteristiche di anonimato, o più precisamente di "pseudonimo" e, soprattutto, per l'opportunità di sperimentare ruoli inediti e identità fittizie.
Inoltre, la comunicazione telematica, in quanto strumento di conoscenza al di là dei limiti spazio-temporali della corporeità, determina elementi di onnipotenza e di avidità, accompagnati da vissuti maniacali e illusori rispetto al possesso e al controllo dell'informazione, con un complementare aspetto inconscio di tipo depressivo e/o depersonalizzante causato dall'inevitabile relativa falsificazione dell'informazione stessa da parte dei media, immersi e sommersi nell'anonimato collettivo.
Sulla rete tutto è visibile, tutto è comunicabile, non vi sono più segreti, con la tendenza ad annullare la dimensione dell'interiorità, spostandola sul versante della visibilità, della trasparenza.

Aspetto positivo, e formativo, dei social network è la possibilità soddisfare i bisogni di supporto sociale e di costruzione del Sé.
Infatti, da una parte è possibile usare i social network per cercare di offrire supporto (vedi tra questi i numerosi forum, i blog, e i gruppi telegram), da un’altra parte è possibile utilizzarli per raccontarsi e in questo modo definire meglio la propria identità sociale, ma anche, al contrario, per leggere i racconti degli altri in modo da confrontarsi con essi (pensiamo al grande supporto e all’informazione, rispetto ad anche solo 10 anni fa, che le persone appartenenti alla comunità LGBQT possono tratte dalla possibilità di entrare in contatto con persone che hanno superato, o che stanno vivendo, lo stesso momento di ridefinizione/affermazione personale).
Sui social network ogni soggetto può organizzare la propria presentazione di sé in maniera strategica. Nella vita reale uno dei problemi principali è che non si può cambiare radicalmente: ad esempio, se sono basso continuerò ad esserlo anche se vorrei essere diverso; oppure il cambiamento desiderato richiede tempo e sforzi prolungati: la timidezza, ad esempio, non può essere superata rapidamente. 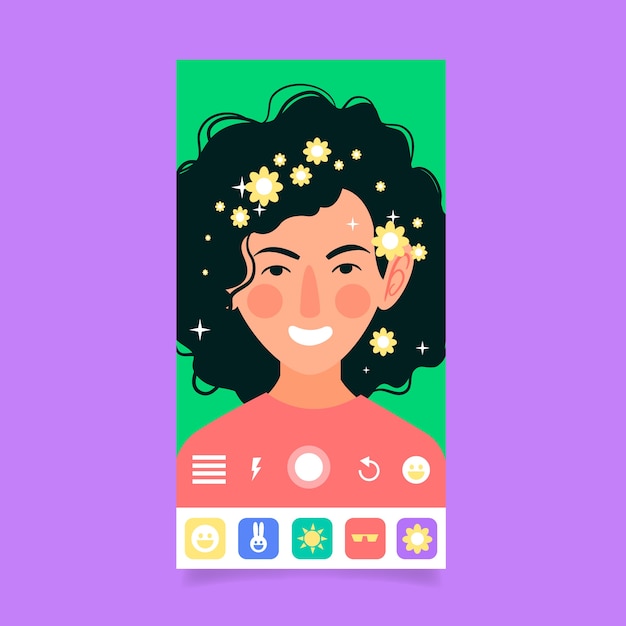
Nei social network, invece, se non dichiaro esplicitamente la mia identità – per esempio usando uno pseudonimo, o utilizzando un filtro che cancella, o minimizza, quel mio difetto che proprio non mi piace –posso sperimentare nuovi modi di essere. La psicologa americana Sherry Turkle [1997] ha chiaramente identificato nei nuovi media il contesto ideale per sperimentare diversi aspetti della propria identità, il quale è un aspetto centrale nello sviluppo individuale, che ha un ruolo centrale nell’adolescenza ma che continua a essere importante anche nell’età adulta.
E' anche vero che i social network permettono anche agli altri componenti della nostra rete di poter intervenire facilmente sulla nostra identità sociale. A questo proposito, Galimberti [2011] parla di intersoggettività enunciativa per sottolineare come la soggettività non sia indipendente dall’esperienza interattiva dei soggetti. Ciò può avvenire in maniera diretta, postando un commento sulla bacheca o sotto una foto, o in maniera indiretta attraverso l’uso del tag, con cui nei social network è possibile associare a un amico, senza che lui lo voglia, un’immagine in cui lui è presente o una nota di testo a lui riferita. Questo fenomeno può portare a cambiamenti imprevisti della propria identità sociale (molti datori di lavoro controllano i social del futuro dipendente prima di procedere con l’assunzione) e, se pensiamo ai fenomeni più gravi di cyber bullismo, anche a risultati tragici (es: video o scatti intimi postati in rete senza la volontà del soggetto).
Il risultato finale che si ottiene da questi processi è una <<identità fluida e plurale>>, che è allo stesso tempo flessibile ma precaria. Un’identità di questo genere può costituire un problema per un adolescente che sta cercando di costruire la propria identità.
 A questi rischi se ne aggiunge un ulteriore, quello della dipendenza dalla tecnologia e dai social network, visti come unica fonte di sicurezza, in contrapposizione all’incertezza e alla mancanza di controllo sperimentati nella vita quotidiana, elementi che sta contraddistinguendo, in particolare, l’ultimo anno tra confinamento e didattica a distanza.
A questi rischi se ne aggiunge un ulteriore, quello della dipendenza dalla tecnologia e dai social network, visti come unica fonte di sicurezza, in contrapposizione all’incertezza e alla mancanza di controllo sperimentati nella vita quotidiana, elementi che sta contraddistinguendo, in particolare, l’ultimo anno tra confinamento e didattica a distanza.Secondo la psicologa statunitense Young, i soggetti più a rischio per lo sviluppo di un Internet Addictions Disorder sarebbero individui tra i 15 e i 40 anni di età, con difficoltà socio-comunicative dovute a precedenti problemi psicologici e psichiatrici, sia familiari che relazionali. In particolare, sarebbero maggiormente esposte alla nuova sindrome personalità caratterizzate da tratti ossessivo-compulsivi, tendenti al ritiro nelle relazioni sociali e/o con aspetti di inibizione nei rapporti interpersonali per la quali la dipendenza da internet può rappresentare un nuovo tipo di comportamento di evitamento che porta il soggetto a rifugiarsi nella rete per non affrontare le problematiche esistenziali. Basti pensare al recente fenomeno degli “Hikikomori”, termine giapponese che significa letteralmente "stare in disparte" e che riguarda quei soggetti che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori.
 Tutti i sistemi di messaggistica (whatsapp, telegram, DM ecc…) e i social funzionano in base al meccanismo dopaminergico. La dopamina è un neurotrasmettitore che, tra le sue varie funzioni, controlla i meccanismi di ricompensa e di piacere, e che si attiva quando siamo in attesa di una risposta. Curiosità: la dopamina è la stessa sostanza che si attiva durante l’assunzione di cocaina o quando siamo alle prese con il gioco d’azzardo. Il vero giocatore d’azzardo non diventa patologico perché vuole vincere a tutti i costi, ma per le sensazioni che prova nell’attesa di una risposta che non può prevedere, e ciò attiva un meccanismo compulsivo. In questo senso è facile intuire come queste piattaforme possano creare dipendenza. Quando noi cambiamo immagine del profilo, scriviamo un post, pubblichiamo una storia o scriviamo in una chat, noi attendiamo una risposta che vada a convalidare quanto noi abbiamo mostrato al mondo virtuale, ecco che entra in circolo la dopamina. Risulta importante quindi cercare di regolare il tempo passato online, soprattutto perché il rischio è quello di attivare un meccanismo del tipo “tutto e subito”, che non fa apprendere a tollerare la frustrazione, elemento fondamentale per il sano sviluppo dell’essere umano.
Tutti i sistemi di messaggistica (whatsapp, telegram, DM ecc…) e i social funzionano in base al meccanismo dopaminergico. La dopamina è un neurotrasmettitore che, tra le sue varie funzioni, controlla i meccanismi di ricompensa e di piacere, e che si attiva quando siamo in attesa di una risposta. Curiosità: la dopamina è la stessa sostanza che si attiva durante l’assunzione di cocaina o quando siamo alle prese con il gioco d’azzardo. Il vero giocatore d’azzardo non diventa patologico perché vuole vincere a tutti i costi, ma per le sensazioni che prova nell’attesa di una risposta che non può prevedere, e ciò attiva un meccanismo compulsivo. In questo senso è facile intuire come queste piattaforme possano creare dipendenza. Quando noi cambiamo immagine del profilo, scriviamo un post, pubblichiamo una storia o scriviamo in una chat, noi attendiamo una risposta che vada a convalidare quanto noi abbiamo mostrato al mondo virtuale, ecco che entra in circolo la dopamina. Risulta importante quindi cercare di regolare il tempo passato online, soprattutto perché il rischio è quello di attivare un meccanismo del tipo “tutto e subito”, che non fa apprendere a tollerare la frustrazione, elemento fondamentale per il sano sviluppo dell’essere umano.

Ma come si traduce e si applica quanto detto a questa fase storica che stiamo attualmente vivendo?
Durante i primi mesi del 2020, caratterizzati dal lock-down, ma anche nei successivi periodi di restrizione (che per i ragazzi, in particolare, ha comportato, in maniera saltuaria, la chiusure delle scuole, dei luoghi ricreativi in cui incontrarsi, e lo stop alle attività sportive), internet e i social hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, un importante strumento di evasione da questa realtà tragica che nessuno di noi era pronto ad affrontare.
Siti ed applicazioni come skype, zoom, whatsapp, ecc…ci hanno permesso di restare in contatto con i nostri amici e parenti, non potendoli sempre vedere fisicamente; ci ha permesso di proseguire con alcune delle nostre routine, tra cui le lezioni scolastiche, universitarie e di alta formazione, lo smart-working, le varie dirette con personal-trainer o fitness guru, gratis e a disposizione per gli sportivi a casa; ci ha permesso anche di apprendere e coltivare nuovi e vecchi hobby grazie ai numerosi tutorial di cucina, di pittura, di trucco, di giardinaggio ecc…
Tuttavia, trovo interessante, a questo proposito, riportare alcuni dati tratti da un’indagine svolta da Associazione nazionale Di.te (Dipendenze tecnologiche, GAP, cyberbullismo), in collaborazione con skuola.net. Sebbene da tale indagine sia risultato che dei 9145 ragazzi, tra gli 11 e i 21 anni, intervistati il 90% utilizzi il web per restare in contatto con gli altri, ben il 74% degli stessi utenti ha affermato di star soffrendo di solitudine. Lo psicologo, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Di.te. Giuseppe Lavenia, ha commentato tali dati affermando “Seppur questi strumenti aiutino a mantenere i contatti, il senso di solitudine percepito dal 74% dei ragazzi ci dice che la tecnologia è, si, social, ma non è per nulla socializzante. Fa sentire soli e non contiene le ansie […] I device, inoltre, attivano il circuito della ricompensa e hanno la capacità di diventare magnetici, dando il via in alcuni casi a vere e proprie dipendenze".
Cosa fare quindi?
è importante stabilire delle regole nel contesto familiare che possano valere per i ragazzi ma anche per i genitori. È importante specificare ciò, in quanto oggi giorno non sono solo gli adolescenti ad aver sviluppato una sorta di dipendenza dai social media, ma anche gli stessi adulti. I bambini apprendono da noi il modo in cui comportarsi, e spesso essi ci emulano anche nel comportamento digitale. Importante è quindi stabilire dei momenti di detox dallo schermo, il quale in questo tempo di COVID, come ci dicevamo, viene utilizzato non solo per motivi di svago ma anche per lavoro e studio.
Ad esempio si potrebbe stabilire che a pranzo e a cena non si accenda la televisione e che non si usi il cellulare, in favore della creazione di uno spazio di condivisione, un luogo in cui aggiornarsi ed incontrarsi nelle diverse generazioni; oppure, soprattutto adesso che le norme in merito sono meno stringenti, si può promuovere una sana passeggiata all’aria aperta, nel rispetto, ovviamente, delle norme sanitarie vigenti.
A quei genitori poco “digitali”, invece, il consiglio è quello di iniziare a conoscere queste piattaforme tanto importanti per i propri bambini. La distanza digitale tra genitori e figli può tramutarsi anche in distanza relazionale, in quanto, come dicevamo in precedenza, una parte dell’identità dei ragazzi passa attraverso i social. Non avere consapevolezza circa questi luoghi virtuali in cui i ragazzi, ma anche sempre più bambini, trascorrono gran parte della giornata, ci impedisce di essere pronti a riconoscere e ad agire in caso di comportamenti a rischio, in quanto non si può aiutare un figlio se non si sa cosa sta facendo.

Bibliografia
Del Miglio, C., Gamba, A., & Cantelmi, T. (n.d.). Contributo allo studio di variabili psicopatologiche correlate all’uso-abuso di internet. A contribution to the study of Internet use/abuse-related psychopathological variables. Retrieved
Marone, F., & Striano, M. (2012). Cultura postmoderna e linguaggi divergenti. Milano: FrancoAngeli.
Riva, G. (2012). Psicologia dei nuovi media. Bologna: Il Mulino.
Riva, G. (2010). I social network. Bologna: Il Mulino.



